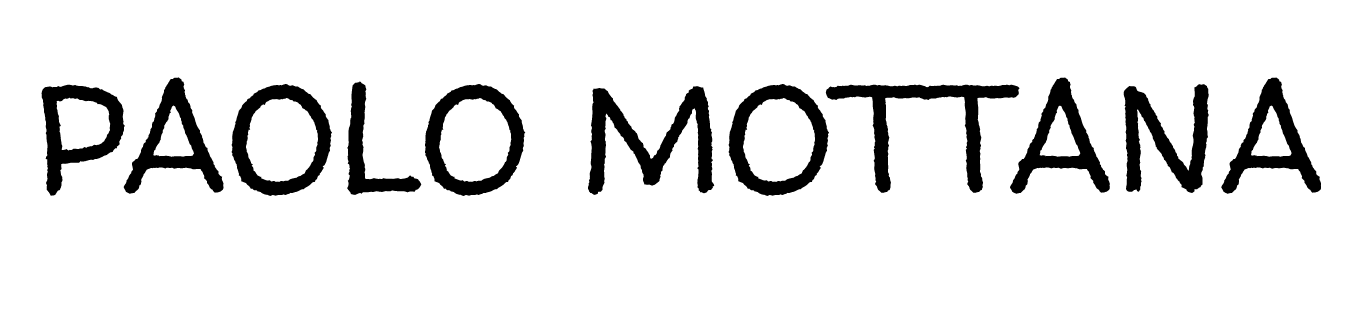Il lavoro è il grande imperativo. Esaurita e vituperata oltre ogni limite (anche da molti dei suoi protagonisti ahimè) la controcultura degli anni ’60 e ’70, nessuno osa più criticare quello che a buon diritto si può considerare il ritrovato e unanimemente plaudito mito del lavoro, anzi il feticismo del lavoro. Tutti vogliono lavorare (anche nelle condizioni di sfruttamento più spaventose), la mancanza di lavoro precipita in uno stato di prostrazione con aggiunta di senso di colpa e frustrazione che ha pochi rivali. Non solo: quando lo si ha, se ne vuole di più, la gara a riempire la propria agenda di impegni è, senza ombra di dubbio, una delle gare più spietate e brutali. La sbirciatina che il collega getta sulla tua agenda, sperando che si riveli semivuota, è inevitabile. Per quanto mi riguarda, concedo molte soddisfazioni ai colleghi. E temo di non riuscire a far loro capire che, per me, si tratta di un motivo di vanto. Questa è la situazione, su cui bivaccano i manipoli del fascismo culturale che promuovono la nostra vita all’incontrario, nella quale le esigenze dell’economia e la gogna del lavoro sono considerati gli unici parametri in base ai quali regolarsi. Chi non ha lavoro non è solo un disoccupato o inoccupato ma anche un reietto. Lavorare non “stanca” più, lavorare è un imperativo etico, sociale e persino estetico. Il lavoro rende liberi e belli. Evviva. Il lavoro è una religione, come dice bene Antonio Saccoccio in un suo recente libro. Certo, qualcuno arcignamente mi obietterà che criticare il lavoro, in modo poi così generico, è non solo stantìo, ma anche ingiusto, considerato che senza lavoro non si campa. Considerato che il lavoro fornisce l’autonomia, è il fondamento della “cittadinanza”. Vero. Ma senza critica, una critica serrata, spietata, anche solo la remota possibilità che si possa intravedere all’orizzonte una società dove il lavoro, quello “alienato”, si intende, possa ridursi, sarà sempre più inverosimile. Certo, una quota di lavoro alienato dovrà, e a giusto titolo, essere distribuita come impegno sociale, a carico di tutti (pena l’essere non socialmente legittimati, come spiegava bene André Gorz), ma è del tutto chiaro che il lavoro umano è sempre meno necessario e che per renderlo tale occorre continuamente inventarlo o inventare crisi che simulino la sua mancanza: il lavoro, sembra incredibile doverlo dire ancora, lo fanno ormai in larga misura le macchine. Ed è del tutto necessario arginare quel mostro divoratore che è l’imperativo della “crescita”, su cui è fondata in larga misura la produzione di merci e lavoro del tutto superflui. Se le cose si allineassero con la costellazione dei nostri bisogni più autentici, al centro delle nostre preoccupazioni dovrebbe esserci un ben altro tipo di lavoro, lavoro creativo, autodeterminato. Di quello, un lavoro non retribuito, gratuito, frutto della pura volontà di creare, di agire -stante la congiuntura sulle cui logiche fittizie agisce l’ideologia di questo decrepito capitalismo-, si parla invece sempre pochissimo. Il lavoro lavoro, quello che garantisce ricavi ai “padroni”, quello invece continua a ricattarci, sottomettendoci alle sue sempre più raffinate tecniche di sfruttamento, di soggiogamento, di condizionamento profondo. Ma soprattutto al furto sistematico delle nostre vite e del nostro tempo che, come noto (ai più lucidi), è l’unica autentica ricchezza cui si possa seriamente aspirare. Tempo da scegliere e da dedicare a ciò che si ama, che ci appassiona, che ci soddisfa. Solo pochissimi privilegiati (a spese degli altri), o vagabondi e obiettori consapevoli spesso emarginati (sotto osservazione e pronti ad essere “recuperati” dai servizi sociali), oggi hanno la possibilità di esercitare la libertà di disporre di gran parte del proprio tempo. Tutti gli altri sono schiavi, schiavi anzitutto dell’ideologia dominante ma poi però drammaticamente di sé stessi, dei propri complessi, della propria avidità e della terribile congiuntura che li vede incapaci di reggere un pensiero che non sia già in partenza castrato dalle ovvietà del conformismo globale. Lavorare meno, lavorare tutti, lavorare meglio. E poi: non lavorare. Occorre ancora una volta rivolgersi a chi, da secoli, e specie da quando il lavoro, con l’avvento della civiltà industriale, è diventato quello che è oggi, cioè, paradossalmente, un valore (mentre non lo è stato pressocchè mai in alcuna altra civiltà compresa la nostra, almeno fino a che il fare non è stato sottoposto alla legge infernale del profitto), lotta contro il lavoro, per spezzare il suo rinato feticismo e per esigere ciò che ci è dovuto: il nostro tempo, la nostra libertà, il nostro desiderio. Da Gorz a Vaneigem, da Hakim Bey a Marcuse a Russell a Illich, da Kropotkin al “Gruppo Krisis”, da Nietzsche a Lafargue al recente Philippe Godard, occorre dire basta al culto del lavoro e rivendicare ancora una volta e poi ancora il “tempo liberato”, una (anti)pedagogia del “tempo liberato” che si muova violentemente in antitesi con l’ideologia massiccia che, dalle organizzazioni sociali alle imprese, alle istituzioni, ai ministeri, ci vuole inchiodare alla ruota del supplizio che da sempre, e non a caso, si chiama lavoro. Un tempo liberato che non emargini, tempo di tutti, tempo di vita, tempo di integrazione, tempo festivo, tempo di intense passioni. Occorre rovesciare un mondo fondato sulle esigenze dell’economia e sostituirlo, al più presto, con un mondo fondato sul desiderio, il desiderio irrinunciabile di riappropriazione, di godimento del proprio tempo. “si sente oggi che il lavoro come tale costituisce la migliore polizia e tiene ciascuno a freno e riesce a impedire validamente il potenziarsi della ragione, della cupidità, del desiderio d’indipendenza. Esso logora straordinariamente una gran quantità d’energia nervosa, e la sottrae al riflettere, allo scervellarsi, al sognare, al preoccuparsi, all’ amare, all’odiare” (F.Nietzsche)